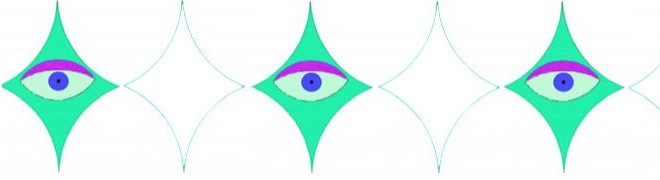da Enrico Comes | Ott 30, 2018 | Maldoror
Democrazia e demagogia. Questo nesso era conosciuto già dagli antichi greci. Le loro riflessioni hanno ancora qualcosa da dirci.
Una “pazzia notoria”: cosi Alcibiade, costretto a rifugiarsi a Sparta dopo la vicenda dei misteri Eleusini, definiva la democrazia, secondo quanto riportato da Tucidide. Tralasciando questioni filologiche sull’attendibilità dei dialoghi tucididei, quello che qui interessa è il giudizio di Alcibiade sulla democrazia.
La democrazia e i demagoghi ai tempi di Alcibiade
Stava accadendo che quel sistema di governo nato all’incirca nel VI secolo a.C, dopo cinquant’anni di relativa stabilità, iniziava ad esser interessato da un fenomeno particolare. Uomini provenienti dalle fila del “demos” tentavano di porsi ai vertici del sistema democratico, attraverso discorsi assembleari tesi ad accattivare il favore dell’assemblea stessa. Costoro, secondo quanto scritto da Aristotele [1], erano infatti chiamati “demagoghi”, letteralmente adulatori del popolo. Occorre dire che quando si fa riferimento al popolo in queste circostanze, si intende quella massa di poveri che, costretti a lavorare per vivere, non avevano la possibilità di esser iniziati a forme d’educazione culturale (diversamente dgli aristocratici da cui peraltro proveniva lo stesso Alcibade). Contrariamente a quanto le fonti, di matrice filo aristocratica, dicevano su costoro, oggi sappiamo che quei “demagoghi” erano in realtà puntuali riformatori del sistema democratico, che tuttavia cercavano realmente di controllare servendosi di tanta retorica.
Dallo studio della della democrazia greca sembra emergere anzitutto la presenza di due parti fra loro contrapposte, schematicamente potremmo dire una popolare ed una aristocratica.
E poi, la stretta correlazione fra democrazia e demagogia: è quanto vogliamo sottolineare al di là di giudizi schiettamente storici. Questo lo sapevano bene i contemporanei di Alcibiade, fra cui il famoso commediografo Aristofane, lo sapeva bene Platone nel IV secolo ed anche Aristotele, che proprio a tale problema ha dedicato gran parte della sua riflessione.
Per Aristotele, infatti, il binomio democrazia-demagogia era tutt’altro che casuale, anzi la demagogia era a suo dire, una delle forme che costituiva il sistema democratico; giungendo nella Politica a tracciare delle prove di tale correlazione. Certo molte di queste tesi oggi sono insostenibili, poiché gli attuali sistemi democratici hanno sviluppato, nel corso della storia, sistemi che arginassero la deriva demagogica insita nella democrazia (si veda in questo senso le costituzioni).
Teste pensanti o folla scomposta?
Tuttavia c’è una tesi sostenuta da Aristotele che potrebbe ancora dirci qualcosa. Nella democrazia demagogica i più, egli dice, sono sovrani non presi uno per uno, ma tutti insieme [2]. Per meglio chiarire, Aristotele continuava facendo riferimento ad un passo dell’Iliade in cui Odisseo, convocato da Agamennone con altri capi militari, si schierava contro l’autorità dei molti.
Aristotele cerca allora di capire quale “molteplicità di capi” Omero ritenesse non buona, se quella tipica della democrazia demagogica o quella in cui più persone comandano, prese individualmente. Era di fatto accaduto che condizionati dalle parole di Agamennone, il quale lasciava intendere un possibile rientro a casa, i guerrieri si trasformassero in una folla scomposta e messo da parte il rigore militare, corsero verso le navi pronti a salpare. Solo l’intervento di Odisseo, che parlò con ogni singolo capo militare, pose fine al trambusto [3].
Il popolo che si lascia abbindolare dal demagogo, sembrava allora dire Aristotele, assomiglia a quella massa di soldati. Non una molteplicità fatta di teste pensanti, come il consiglio degli aristoi che Agamennone aveva riunito prima di convocare l’assemblea, ma una massa vociante che si muove all’unisono, reagendo a stimoli elementari. Tutto questo, a suo avviso, era possibile dal momento che il popolo non padrone di sé e pertanto si lasciava ammaliare dalla chiacchiera demagogica.
Democrazia e discorso demagogico ai tempi del governo Lega-5stelle.
Nel Novecento non sono mancati pensatori che hanno ribadito la tesi aristotelica, si pensi a Weber. Ma anche chi non avesse letto una pagina di Weber può benissimo constatare, oggi, quanto la democrazia attuale sia ancora esposta a derive demagogiche. Questo perché è il discorso politico democratico ad essere in sé esposto ad un uso demagogico; essendo un discorso che non ha finalità conoscitive (come quello scientifico) costituito cioè da puri enunciati performativi. L’efficacia del discorso demagogico deriva, d’altra parte, dal fatto che non si propone mai di mettere in discussione le opinioni diffuse, ma di nutrirsi delle stesse. Il punto, allora, sembra essere quello colto da Aristotele: il demagogo dice al popolo ciò che il popolo vuole sentirsi dire.[4]
Per quanto il legame democrazia-demagogia sia evidente, tuttavia ci sono fattori molteplici che concorrono a rinvigorire il fenomeno demagogico. Primo fra tutti, come ha fatto notare Laclau [5], in un contesto di crisi socio-economica, in cui il corpo sociale è lasciato a sé, privo di corpi intermedi; è evidente che la presa della retorica demagogica sarà maggiore. A questo punto sembra inutile ribadire che la creazione dei partiti di massa, oltre alle innumerevoli altre forme di associazionismo politico, rispondeva proprio a questa esigenza.
Ovvero, pur nella loro diversità, quelle parti (partiti) esprimevano e articolavano le domande provenienti dal basso, educando alla pratica democratica. Perché in fondo è di questo che si tratta: esser educati alla democrazia. Per anni abbiamo ritenuto la democrazia un sistema “scontato”, eliminando quelle pratiche di socialità che di essa sono il cuore pulsante: dal pensiero politico democratico costruito attraverso la partecipazione attiva, siamo passati all’opinionismo webeta.
In conclusione, che la democrazia sia esposta alla demagogia sembra esser chiaro. In questo stava la “pazzia notoria” di cui lamentava Alcibiade. Ciononostante ancor più folle sarebbe non tentare di arginare la deriva demagogica che sempre minaccia gli equilibri democratici. È nella lotta articolata fra le parti (i corpi intermedi di Laclau) che la democrazia trova la sua ragion d’essere, ristabilendo gli equilibri interni, non nel discorso ammaliatore. Forse per questo la democrazia continua ad essere una pazzia notoria.
E. Comes
[1] Aristotele, Politica, V, 1313b.
[2] Aristotele, Politica, 1292 a 10.
[3] Iliade II, 204.
[4] Pazè, La demagogia, ieri e oggi.
[5] Laclau, La ragione populista.

da Enrico Comes | Mag 3, 2018 | Maldoror
Dopo alcuni giorni dalla festa del lavoro, dopo la sbronza post concertone del primo maggio, anche noi momiziani vogliamo dire la nostra su questa giornata a partire da una riflessione sul significato della parola ‘lavoro’. Vogliamo fare un piccolo “gioco di parole” per capire che cosa era il lavoro e che cosa non è più. Da sempre il concetto di lavoro ha significato qualcosa di faticoso e vitale al tempo stesso.
Nei dialetti del Sud-Italia si usa il verbo travagliare, che rimanda alla fatica dolorosa e creativa del partorire; identico per lo spagnolo trabajo e il francese travail. Diverso ma altrettanto faticoso è il concetto del labor nei dialetti del Nord-Italia. Gli inglesi più a Nord “workano”, faticano cioè con uno strumento (da cui il tedesco Werkzeug per indicare lo strumento da lavoro). Non così semplice è la situazione in Germania; perché se dalle parti di Basilea il lavoro è Schaffen e rimanda al creare, nella zona di Norimberga il lavoro è rigorosamente Arbeit, concetto severissimo che ci spedisce nel cuore della fredda Russia. Questo perché il suffisso di Arbeit (ARBT) è lo stesso per il russo RAB, da cui ha origine la parola rabynya, che significa schiavo, e il verbo lavorare “rabota”. Così tanto a Norimberga quanto in Russia il lavoro è quasi cosa per robot.
E oggi? Le grandi trasformazioni tecnologiche ci consentono di liberare forza lavoro ottenendo guadagni di tempo come mai prima nella storia. La maggior parte dei lavori degradanti può esser svolta da macchine, che al tempo stesso producono ricchezza da distribuire egualmente in tutta la società.
Eppure diversi mesi fa, la moglie di un operaio ILVA, intervistata in merito alle polemiche sull’acciaieria, ha detto che preferirebbe morire di tumore che non di fame. Le persone “impiegate” in Amazon cominciano a denunciare le condizioni disumane cui sono costrette, sino al limite estremo di non poter andare in bagno per mantenere alto il livello di produzione. Certo situazione non diversa per tutti gli “impiegati” di Uber, Foodora, Deliveroo: lavoratori e lavoratrici costretti a guidare o pedalare per chilometri per consegne sottopagate; controllati dall’occhio virtuale di una App che licenzia chi è stanco e offre bonus a chi non sciopera.
Ma allora cosa non funziona? Perché il progresso tecnico ci rende sempre più schiavi invece di liberarci? Non si crederà mica di risolvere ogni male bloccando la tecnica, congenita con l’uomo?
Fin dai suoi esordi, con la rivoluzione industriale, il capitalismo separa l’aspetto vitale del lavoro inteso come attività (Arendt) da quello produttivo. Generando plusvalore e profitto da parte di chi detiene i mezzi di produzione ed alienazione per lavoratori e lavoratrici (Marx).
Va rifondata una nuova etica del lavoro, a partire da un equo processo di redistribuzione delle ricchezze. Siamo giunti nella paradossale condizione di poterci liberare dall’idea del “lavoro” come unica via faticosa per la realizzazione umana, ma d’altra parte siamo piegati a condizioni lavorative dis-umane. In una delle sue ultime conferenze lo scienziato S. Hawking, scomparso di recente, diceva: ”Se le macchine producono tutto ciò di cui abbiamo bisogno, il risultato dipende da come le cose sono distribuite. Se la ricchezza prodotta dalle macchine sarà distribuita, tutti potranno vivere una vita agiata. Se i proprietari delle macchine premeranno con successo contro la distribuzione della ricchezza, allora molti saranno ridotti alla povertà”.
Enrico Comes

da Enrico Comes | Apr 29, 2018 | Maldoror
Anticipata l’inaugurazione dei Giardini in città a Monopoli dall’amministrazione uscente di centro destra, che si procura così una passerella elettorale a spese dei cittadini. In politica certe azioni valgono più di mille parole e bisognerebbe tenerne conto per distinguere le chiacchiere dai contenuti.
In questa bizzarra società abbiamo dimenticato l’importanza delle azioni. Agiamo senza ragionare sulle conseguenze, perché ciò che conta è quello che poi se ne dirà.
Eppure, in barba a chi sostenendo un finto relativismo ritiene che tutto si equivalga, occorre notare che, quanto diciamo per conto di noi stessi, è in realtà una grande narrazione dai caratteri giustificatori. E’ agendo che diamo prova di ciò che siamo.
Principio mai più evidente nel mondo della politica, in cui ormai di parole ce ne sono fin troppe e di fatti sempre più ingiustificabili.
Non fa eccezione neanche la politica a Monopoli, specie in questi mesi di aperta campagna elettorale, che vede il candidato di centro sinistra (Contento) opporsi al candidato di centro destra (Annese).
Certo, le parole durante una campagna elettorale sono fondamentali. Ma come si distinguono le chiacchiere dai contenuti ragionati? I progetti reali dalle promesse illusorie? E’ poi così vero che tutte le parole sono uguali tanto destra quanto a sinistra?
La risposta sta nei piccoli gesti che seguono a queste parole. Ad esempio risulta alquanto strano che, lo scorso sabato 28/04, l’amministrazione uscente (di centro destra) abbia anticipato l’inaugurazione di un evento (I Giardini in Città) che solitamente si svolge tra Giugno e Luglio.
Inutile dire che tale serata è diventata momento di passerella per tutta la coalizione di centro destra che, con sorrisi e strette di mano, girovagava tra le istallazioni di aree verdi artificiali (queste sì realmente favolose) organizzate dai vivai locali. Gli stessi a cui, peraltro, questa amministrazione ha affidato la manutenzione delle rotatorie urbane e la cura di alcune aree verdi pubbliche ma che sfortunatamente non vedono la loro attività remunerata già da tempo.
Insomma, proprio non riusciamo a capire come mai un evento cittadino, reso cioè possibile anche con il contributo dei cittadini, sia stato utilizzato per fini politici.
Fatti che contrariamente alle parole, mostrano la reale differenza fra i due schieramenti politici in corsa per le prossime amministrative.
E.Comes

da Enrico Comes | Dic 31, 2017 | Maldoror
Il 2017 è ormai terminato e con esso anche la questione IUS SOLI sembra essere archiviata, dopo mesi di sterili discussioni. Eppure numerosi giornali continuano a dedicare pagine al tema “cittadinanza“, nella speranza di mantenere viva la discussione. Tanto che recentemente l‘Espresso ha definito quella per lo IUS SOLI, “una battaglia di civiltà che non deve finire”.
Chiariamo subito la visione: che vi sia un’emergenza umanitaria sarebbe sciocco negarlo. Così come lo è pensare che questo dramma possa continuare ad accadere senza alcuna regolamentazione politica. Pertanto le perplessità non sono legate al voler rendere “italiani” individui altrimenti etichettati come “migranti”. Il vero problema è la “cittadinanza” in sé.
Il dispositivo della cittadinanza
Siamo abituati all’esistenza di questo dispositivo, tanto da non interrogarci sulla sua origine e sul suo significato, se non in termini strettamente tecnici. Come già notava Hannah Arendt, diamo per scontato che un individuo al momento della nascita debba esser inserito in un ordinamento statuale, così da trovarsi soggetto alle leggi e al sistema politico di uno Stato. Non da ultimo, tale meccanismo è aspetto tipico degli stati moderni, detti Stati Nazionali, che fanno della “nascita” il principio utile per iscrivere gli individui al proprio interno. Ma per quanto poi ci si possa arrovellare sui criteri procedurali di iscrizione degli individui nello Stato, IUS SOLI o IUS SANGUINIS, i fenomeni di inclusione e di eslcusione dalla cittadinanza permangono.
Se la comunità politica funziona come un club
Occorre forse ragionare per altre vie: se la “comunità politica” funziona come un “club” nel quale si può essere ammessi o dal quale ci si può veder rifiutare l’accesso, “ci si deve domandare come i membri di diritto siano stati cooptati, come abbiano stabilito le regole di ammissione e come si traduca la loro partecipazione attiva nella preservazione di quelle regole” (1). Le implicazioni pratiche di questo ragionare sono evidenti; ad esempio: non ci sarebbe esclusione delle donne dalla cittadinanza o da certi diritti civili, senza la costituzione di un modello di cittadinanza che ha funzionato (continua ancor oggi) come un “club” di maschi. Lo stesso vale, mutatis mutandis, per i fenomeni di discriminazione razziale e culturale, che imprediscono ad alcuni ESSERI UMANI l’accesso alla cittadinanza, o al godimento di diritti ritenuti inalienabili.
La cittadinanza si basa su dinamiche di inclusione-esclusione
Tutto ciò basta per riconoscere quanto è la stessa “comunità politica” ad escludere. Detto in altri termini, sono sempre dei cittadini che, in quanto tali, escludono dalla cittadinanza creando dei non-cittadini; così da poter giustificare a se stessi la propria cittadinanza come un’appartenenza comune.
In forza di quanto detto, la questione resta aperta: invece di disquisire tecnicamente dei criteri della cittadinanza, occorrerebbe discutere della cittadinanza in sé. Fu detto già tempo fa “alcune persone sono nella società, senza essere della società“. La dinamica di inclusione ed esclusione continua a generare drammatiche realtà, è giunto il momento di interrogarsi seriamente sulla cittadinanza.
(1) E. Balibar, Cittadinanza, Bollati Boringhieri, 2012, p. 102
E. Comes
Image: ‘BorderEncuentro2017_Day2_IMG_1227-1’

Found on
flickrcc.net
da Enrico Comes | Nov 15, 2017 | Maldoror
Sempre più frequentemente si parla di post-ideologia in riferimento al processo di liquefazione della sfera politica. Per quanto tale concetto sembrai esser universalmente accettato – tanto da esser opinione comune a destra come a sinistra – ed indicante un reale fenomeno di sfaldamento; tuttavia nasconde la presenza di una macro ideologia perversa imperante.
Nessuno infatti, si definisce post-liberale in un mondo che considera il capitalismo l’unico orizzonte di senso: questa è ideologia allo stato puro!
Parlare di post-ideologia, significa in altri termini, sostenere un certo discorso post-politico, secondo cui qualunque problema di chiara matrice politica viene letto ed interpretato in base a parametri etico-culturali. Non è un caso se la parola migrante ha ormai soppiantato quella di operaio (lavoratore) e se il problema del multiculturalismo, legato all’intolleranza dell’altro e al rispetto dei dritti etnici, ha sostituito quello relativo alle dinamiche di sfruttamento dei lavoratori e alla distruzione del welfare state.
Con ciò non si vuol certo ignorare o sminuire il reale e drammatico problema umanitario; al contrario occorre guardarlo da un’altra prospettiva per restituirgli la giusta dignità.
Di fronte a tale problema, la politica “post-ideologica” si divide su due fronti: da un lato i progressisti con i loro discorsi sul multiculturalismo, dall’altro i populisti anti-immigrazione pronti ad erigere muri.
Quale delle due posizioni è più ragionevole? Se letta in termini post-ideologici, secondo cioè parametri etico-culturali, il multiculturalismo sembra esser la risposta più ragionevole.
Di fatto nessuna posizione lo è: sono entrambi negative se lette in chiave politica. È qui che si nasconde l’ideologia perversa dominante: fingere di riferirsi alle persone e alle loro reali esigenze.
Mentre la post-politica si congestiona sul dibattito etico-culturale, il capitalismo si adatta molto più velocemente ad ogni forma di ethos e di cultura, assecondato da una certa politica ormai disposta a tutto pur di alimentarlo.
Pertanto, tutti i nostri discorsi sui migranti sono funzionali a distogliere l’attenzione dal reale problema politico: il capitalismo. Siamo spinti a credere che la minaccia provenga dall’esterno, da questo Altro, senza capire che ciascuno di noi è altro in sé e soggiogato in un sistema avvolgente e senza scampo. Peraltro, non è sufficiente riconoscere l’astrazione ideologica del capitalismo che prosegue il suo cammino senza preoccuparsi minimamente né dell’ambiente, né dell’uomo (come tenta di fare una certa analisi illusoriamente illuminata). Il problema è che questa “astrazione” è reale nel preciso senso di determinare proprio la struttura dei processi sociali materiali: il destino di intere popolazioni e a volte di Paesi, dipende dall’andamento folle del capitale, che punta alla sua crescita con indifferenza rispetto alle ricadute sociali. Questa è la violenza sistemica del capitalismo che si riversa nella società, molto più efferata di qualsiasi violenza socio-ideologica pre-capitalista. La violenza oggi esercitata è anonima, non più attribuibile a persone in carne e ossa e alle loro “cattive” intenzioni.
Per queste ragioni, di fronte ai discorsi post-ideologici, all’odio etnico e alla violenza, occorrerebbe rifiutare la tipica idea multiculturalista secondo cui per combattere l’intolleranza etnica, si debba imparare a rispettare e convivere con l’Altro, sviluppando tolleranza. Il vero modo di sconfiggere questi sciocchi discorsi, come quelli che vedono nella costruzione di muri l’unica alternativa, non è una soluzione etica. Abbiamo bisogno di odio, ma un più corretto odio politico: un odio diretto al nemico politico comune!
E. Comes